Il Corpus Hermeticum testimonianza di una gnosi
precristiana(cf: Eduard Lohse, L'ambiente
del Nuovo Testamento,Brescia 1993
" ...Pensieri gnostici predominano nella raccolta dei diciotto
trattati che costituiscono il cosiddetto Corpus Hermeticum.
Il dio greco Ermete è detto «tre volte grande» (in greco trismegistos)
e viene identificato col dio egiziano Thoth.
Ermete, per i greci il messaggero degli
dèi e in epoca ellenistica considerato come il dio della sapienza,
si presenta come il rivelatore che porta agli uomini il messaggio divino
e li conduce alla conoscenza. L'istruzione si effettua soprattutto
nel dialogo tra l'uomo e Dio: l'uomo chiede e Dio gli risponde, con una comunicazione
dottrinale che può
essere comunicata soltanto a tu per tu.
Il Corpus Hermeticum non rappresenta un' opera
letteraria unitaria; alla composizione dei diciotto trattati presero parte
più autori, le cui concezioni non sempre coincidono. La maggior
parte fu redatta tra il 100 e il 200 d.c., ma le tradizioni che vi furono
accolte passarono prima per un lungo periodo di trasmissione orale. Vi
si rivelano influssi iranici, babilonesi, egiziani e greci, idee filosofiche
di origine platonica, pitagorica, stoica e in alcuni anche l'eco di concezioni
veterotestamentarie giudaiche.
In nessun luogo, però, questo quadro multicolore lascia intravedere
contatti col messaggio cristiano. Il Corpus Hermeticum costituisce
quindi un esempio quanto mai significativo e interessante di ciò che
fu la visione del mondo di uno gnosticismo non ancora giunto in contatto
e confronto con il cristianesimo.
Apre la raccolta il trattato Poimandres, di
gran lunga superiore a tutti gli altri per l'importanza del suo contenuto.
Il nome Poimandres è probabilmente di origine egiziana, e significava «conoscenza
di dio»; fu in seguito grecizzato e utilizzato a designare il mediatore
della rivelazione.
Il primo trattato del Corpus Hermeticum espone la
cosmologia, l'antropologia e la soteriologia gnostica accatastando materiali
di varia derivazione, amalgamando diverse tradizioni mitologiche per descrivere
l'origine del mondo, la creazione dell'uomo e la redenzione che deve liberarlo
dalla schiavitù.
All'inizio il mediatore della rivelazione si presenta
a colui che la riceve con queste parole: «lo sono Poimandres, lo
spirito della potenza suprema» . A lui viene rivolta la richiesta: «Voglio
essere istruito sull'esistente e comprendere la sua natura, e conoscere
dio» . Egli accondiscende a questo desiderio e inizia a trattare
dell' origine del mondo, dapprima in linguaggio mitologico.
Dio è luce «ma dalla luce...
venne sulla natura una parola santa, e un puro fuoco si levò
dalla natura umida su verso l'alto; era
leggero e acre e insieme potente; e l'aria, che era leggera, seguì il
soffio, salendo dalla terra e dall' acqua sino al fuoco, così che
pareva esservi sospesa. Ma la terra e l'acqua rimasero alloro posto,
mischiate insieme al punto che non si poteva distinguere la terra dall'
acqua. Esse erano mosse dall'azione della parola spirante fuoco percepibile
al di sopra»
.
Dio, che si trova nelle regioni celesti,
generò da sé «un altro spirito come demiurgo che,
in quanto dio del fuoco e del soffio, creò sette intendenti
che avvolgono nei loro cerchi il mondo sensibile» .
Essi reggono il mondo, e ciò significa che determinano il destino
cui il mondo soggiace. Il demiurgo, sottoposto al dio altissimo, ha
impresso alle opere della creazione un moto di eterna rotazione. Grazie
a questa sono stati generati gli esseri viventi e l'aria è stata
popolata di uccelli, l'acqua di pesci, e la terra ha prodotto animali:
quadrupedi, serpenti, rettili, animali feroci e domestici.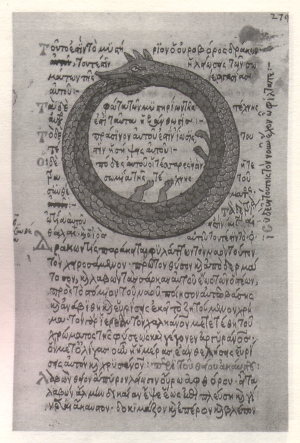
«E’
vero e senza menzogna ed è certo, e il più vero di
tutto
è l’Essere: perché lo si possiede in base all’esperienza,
e ciò di cui si è fatta l’esperienza, questo è
certamente veritiero. Che ciò che è, qui in basso,
è come quello che è, in alto. E ciò
che è, in alto, è uguale a ciò che è,
e che si trova in basso. Per mezzo di lui vengono fatti i miracoli
di una cosa unica: cioè della pietra o «lapidis philosophici»
E come tutte le cose provengono da Uno unico, mediante la
contemplazione di Uno unico; così tutte le cose nascono
da questa unica cosa mediante la composizione e l’unione.
In questo modo: da un ammasso mescolato, o materia mescolata,
su ordine del Creatore onnipotente. Così la nostra pietra
viene concepita e proviene da una materia mescolata che è «shamaijm»,
un acquoso fuoco o un’ignea acqua, il sale e un unico;
oppure: sal, sulphur e merkur.
Il suo
padre è il Sole [luce, fuoco,calore]
La sua
madre e la Luna [acqua]
Il vento
l’ha portato nel suo ventre [aria]
La sua
nutrice è la terra [terra]
Questo
spirito salino volatile è il padre di tutte le perfezioni
di questo mondo. La sua forza è perfetta quando è trasmutato
in terra. Tu devi separare la terra dal fuoco, il sottile dal
grossolano molto sottilmente e dolcemente, con grande comprensione
e ragionevolezza. Egli sale dalla terra verso il cielo e scende
di nuovo in basso nella terra e cosi riceve la forza del superiore
e dell’inferiore. Cosi tu avrai la magnificenza di tutto
l’Universo.
Perciò da te scompariranno tutte le tenebre Questa cosa è tutta
forza, la più forte e potente. Perché
ciò supera tutte le cose sottili e penetra tutto ciò che
è duro e compatto. Così è formato il mondo,
l’universo. Perciò si possono fare con questa
delle cose meravigliose. E la via è questa, cioè come
e stato annunciato in questa descrizione. Per questo sono stato
chiamato Hermes trismegisto, cioè il Mercurius triplo,
perché io posseggo le tre parti della Saggezza di tutto
il mondo. Cosi si è compiuto ciò che io ho detto
dell’effetto della chymia oppure del «lapide philosophorum». [pietra
filosofale]
L'intero cosmo è quindi opera del demiurgo,
soggetto al destino che gli è imposto. La creazione dell'uomo è descritta
con espressioni solenni che lasciano presupporre contatti con testi
biblici:
«Ma lo spirito che è luce e vita, il padre di tutte le cose, generò un
uomo simile a lui, che amò come suo figlio; egli infatti, riproducendo
l'immagine del padre, era molto bello, cosìche dio amò la sua
stessa immagine. A lui sottomise tutta la creazione»
L'uomo
archetipo contemplò l'opera del demiurgo, ma di fronte
allo spettacolo della sua attività creatrice ne divenne
geloso, e volle anch' egli mettersi a creare. Gli intendenti
che governano il cosmo s'innamorarono di lui e ciascuno di
essi lo fece partecipe del suo ordinamento.
E allora
si compì l'avvenimento che fu determinante per il destino
di tutti gli uomini:
«Ed egli, che aveva pieno potere
sul mondo degli esseri mortali e sugli animali privi di ragione, si piegò attraverso
l'armonia (delle sfere), ruppe il loro involucro e mostrò alla
natura inferiore la bella forma di dio. Quando essa lo vide, bellezza
sconfinata, forma di dio con. in sé tutto il potere degli intendenti,
sorrise d'amore, poiché vide i tratti di questa forma meravigliosamente
bella dell'uomo riflessa nell'acqua e la sua ombra sulla terra.
Ed egli, quando nella natura inferiore
vide la sua stessa immagine riflessa nell'acqua, se ne innamorò a
sua volta, e volle abitare là. Nell'istante in cui egli lo volle
si produsse il compimento, e così egli abitò
la forma priva di ragione. Allora la
natura, accolto l'amato, lo strinse a sé, si unirono e si amarono» .
Così
avvenne la caduta dell'uomo archetipo,
che fu trascinato dal mondo superiore a quello inferiore e che stabilì con
la natura un legame che lo incatenò. Con essa egli generò l'uomo
terrestre, che si distingue da tutti gli altri esseri viventi, ma è
anch' esso sottoposto alla condizione
mortale:
«Per questo l'uomo, solo tra tutti gli
esseri che vivono sulla terra, è
duplice: mortale per il corpo, immortale
per l'uomo essenziale. Infatti benché sia immortale e abbia
potere su ogni cosa patisce la morte ed è sottomesso al destino.
Per questo, benché sia al di sopra dell'armonia (delle sfere), è divenuto
schiavo di ciò
che sta sotto a questa armonia; benché sia androgino perché
originato da un padre androgino, benché sia esente dal sonno
perché viene da un essere senza sonno, egli è tuttavia
dominato (dalla brama di amore e di sonno»
Da allora tutti gli uomini, così come gli animali, vivono
quali maschio e femmina. Dio ha comandato loro di moltiplicarsi,
un comando che ancora una volta ricorda chiaramente il racconto biblico
della creazione: «Accrescetevi in crescita e moltiplicatevi
in moltitudine, voi tutti che siete stati creati e fatti creature» .
E a questo ordine divino corrisponde: «e tutti gli esseri
si moltiplicarono secondo la propria specie» .
Il mito della creazione e della caduta
dell'uomo archetipo spiega dunque la condizione attuale dell'uomo,
il cui corpo è
costituito di materia
inerte, ma il cui nucleo divino è di origine celeste.
Chi in base a questa rivelazione conoscerà se stesso
potrà salire verso il bene ed entrare a far parte degli
eletti. Ma chi è pieno d'amore per il corpo e per la materia
resterà a errare nelle tenebre e sperimenterà
la morte nel suo corpo.
Se l'uomo comprende chi è e chi deve essere rinuncerà alle
passioni e agli affetti e si libererà
di tutto ciò che lo incatena al corpo, e quindi al mondo.

Ouroboro : manifestazione di Uno il Tutto.
Versione araba
Con la retta conoscenza si acquista
anche la capacità
di raggiungere l'unica vià possibile verso la salvezza.
Dopo la morte il corpo si disgrega e torna
nuovamente nella materia, così che anche gli impulsi carnali del
corpo svaniscono.
L'anima invece, che può intraprendere il viaggio verso la patria
celeste, nell'ascesa subirà una purificazione ( purgatorio)
; in ogni sfera che attraversa essa depone qualcosa di ciò che
l'ha finora appesantita; dapprima abbandona il potere di crescere
e decrescere, poi l'attaccamento al male, e di seguito il
desiderio ingannevole che in realtà non porta a nulla,
la sete di potere, l'empia arroganza e l'intenzionale temerarietà,
il cattivo desiderio di aspirare alla ricchezza e infine la
perfida menzogna.
Libera da tutte queste passioni l'anima
penetra nell'ottava sfera, che sta al di sopra delle altre
sette, unendosi all'inno di lode di tutte le potenze e di tutte le
anime che vi si trovano e insieme lodano il Padre.
L'anima è
giunta alla sua meta: la sua divinizzazione .
La conoscenza della verità intorno alla natura dell'uomo,
alla caducità del cosmo e alla via della redenzione suscita
in coloro che l'hanno acquistata il desiderio di diffondere la gnosi.
Chi ha ricevuto la rivelazione deve quindi annunciare la bellezza
della devozione e della conoscenza:
«Voi, popoli, voi, uomini nati
dalla terra, voi che vi siete abbandonati all'ubriachezza, al sonno e
all'ignoranza di dio, siate sobri, smettete di gozzovigliare, stregati
da un sonno insensato... Perché voi, uomini nati dalla terra,
vi siete consegnati alla morte pur avendo il potere di partecipare all'immortalità?
Fate ammenda, voi che avete camminato sulla via dell'errore e avete preso
per compagna l'ignoranza.
Liberatevi dalla luce tenebrosa, rendetevi
partecipi dell'immortalità, abbandonate la corruzione»
Chi ha acquistato la
conoscenza divina deve diventare una guida per gli altri uomini
e indicare, come uno che sa, la via della redenzione, mostrando
loro «come e in qual modo essi saranno salvati» .
Il trattato Poimandres
non parla di celebrazioni
cultuali e feste liturgiche
più degli
altri scritti del Corpus
Hermeticum. Non si tratta
di un'assemblea o di
una comunità,
si presenta solo una dottrina
della conoscenza di dio.
Chi l'ascolta e la fa
sua può trarre
da sé le conseguenze. ..."
 Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.
Monumento della cultura gnostica ?
Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.
Monumento della cultura gnostica ?
L’ipogeo degli Aureli (detto anche di Aurelio Felicissimo) è
un monumento funebre privato,postosull’antica via Labicana, nell’attuale
rione Esquilino. Il cimitero venne scoperto nel 1919 all’incrocio tra
viale Manzoni e via Luzzatti, e suscitò l’ammirazione degli studiosi
per il ricco ciclo di affreschi che adorna le pareti e la cui interpretazione
resta ancora oggi un problema aperto.
Il monumento, che non è menzionato in nessuna
fonte letteraria, fu scoperto durante i lavori di costruzione di un garage.
Esso si presenta a due piani: il piano superiore, composto da una sala
che in origine era semi-ipogea e di cui oggi resta solo la parte inferiore;
e, cinque metri sotto, il piano inferiore, composto da due ambienti speculari
e completamente ipogei.
Gli ambienti sono affrescati con scene di difficile
interpretazione, ma databili intorno al 230. Con la costruzione delle
Mura aureliane e il conseguente allargamento del pomerio, il cimitero
fu abbandonato.
Il nome dell'ipogeo deriva da uno dei due ambienti
sotterranei, detto cubicolo degli Aureli, il cui pavimento è
ricoperto da un mosaico in cui Aurelius Felicissimus dedica il sepolcro
ai fratelli Aurelius Onesimus, Aureliius Papirius e Aurelia Prima. Ad
una parete è affissa un'epigrafe marmorea in cui tale Aurelius Martinus
e la moglie Iulia Lydia ricordano la figlia defunta Aurelia Myrsina.
 Nel
locale superiore troviamo raffigurati
Adamo ed Eva senza il “segno
di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero
della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore
della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo
e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne
di fronte al Demiurgo.
Nel
locale superiore troviamo raffigurati
Adamo ed Eva senza il “segno
di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero
della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore
della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo
e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne
di fronte al Demiurgo.
La Conoscenza (Gnosis) apportata
da Naas è la Conoscenza del Bene
e del Male , una Conoscenza Etica ed Ontologica.
A lato della figura di Adamo ed Eva con
il Serpente (Naas) sulla destra troviamo dipinta una figura di maestro
con un rotolo in mano nell’atto di insegnare. Si tratta forse di una figura di
Maestro Gnostico, depositario dell’antica Conoscenza trasmessa
da Naas ai progenitori.
Sempre a lato della figura di Adamo ed
Eva, ma alla sua sinistra troviamo raffigurata una figura grande di
uomo con pallio con a lato una figura antropomorfica dalle dimensioni
più piccole,
che rappresenta forse il Demiurgo. La scena raffigura l’atto della
Creazione dell’Uomo ad opera del Demiurgo .
 Nel
primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi
sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,
in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il
Salvatore, circondato da una specie di
corona con dei piccoli raggi.
Nel
primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi
sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,
in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il
Salvatore, circondato da una specie di
corona con dei piccoli raggi.
L'insegnamento trasmesso dal
Salvatore si può attingere soltanto
guardandolo dal punto di vista degli Apostoli.
Gli apostoli sono raffigurati in atteggiamento magistrale con un
rotolo nella mano.
In un caso abbiamo addirittura un evangelista,
probabilmente Giovanni, raffigurato con la mano
contemporaneamente rivolta verso l’alto nell’atto di insegnare e verso il basso nell’atto
di stringere un rotolo.
Sul soffitto troviamo dipinta una donna velata
con due uomini ai lati, di cui uno con un bastone in mano rivolto verso
il capo della donna.
... Mentre nel Corpus Hermeticum non si fa menzione
di gruppi religiosi, la conoscenza gnostica può essere associata
anche a comunità
di credenti che continuino quelle tradizionali
o siano costituite in modo nuovo.
Le concezioni gnostiche sono così presentate spesso sotto forma
di celebrazioni cultuali del tipo di quelle delle comunità misteriche,
o assumono tratti cristiani; sorgono così comunità miranti
a nobilitare il vangelo attraverso il mito gnostico.
Le idee gnostiche possono anche essere semplicemente
riportate in una predicazione rivolta a coloro
cui è annunciata
la conoscenza salvifica. Così gli scritti ermetici non sono rivolti
a cerchie predeterminate di persone che si radunino
per il culto, ma intende risvegliare i lettori
invitandoli a incamminarsi lungo la strada della conoscenza.
I temi fondamentali presi in considerazione nel
primo trattato vengono continuamente ripresi negli altri, ripetuti in
diverse forme. Dalla serie di questi scritti si distingue soprattutto
il tredicesimo trattato, che verte sulla rigenerazione dell'uomo:
non nel senso di un atto sacramentale, ma solo della conoscenza
di dio. All'inizio si afferma che nessuno può essere
salvato prima della rigenerazione ; per questo è
necessario apprenderne la dottrina, che libera
dall'inganno del cosmo.
Il rigenerato esperimenta una meravigliosa metamorfosi,
egli «sarà figlio divino di dio, il tutto in tutto,
costituito da tutte le Potenze»
Il processo della rigenerazione, che significa divinizzazione,
non è percepibile con occhi materiali, ma si compie come totale
trasformazione in una visione mistico-estatica. La trasformazione
è così radicale che il rigenerato può dire
di essere un altro .
La strada verso il rinnovamento
viene percorsa per libera decisione dell'individuo, che rinuncia
alle passioni che porta in sé. Esse , dodici di numero ,
operavano attraverso il corpo mortale e gli impulsi dei sensi che
si adoperavano a mantenere l'anima nella sua prigione. Ma là dove
c'è conoscenza, che in quanto conoscenza divina illumina
la condizione dell'uomo indicandogli la strada del ritorno a dio,
viene posto termine all'ignoranza
Raggiunta la gnosi, l'ingiustizia
scompare e l'uomo diventa giusto. Ciò
significa che si compie in lui e con
lui un cambiamento ontologico per il quale egli viene divinizzato.
Le dieci virtù che gli sono comunicate cacciano i dodici
vizi, così che l'uomo diventa dio, figlio dell'Uno .
Su questo splendido mistero
lo gnostico conserva il segreto, per proteggerlo dalla profanazione.
Ma gli uomini chiaroveggenti intuiranno con lui cosa è avvenuto
nella rigenerazione, che lo conduce al vero culto e al giusto sacrificio
offerto nella preghiera di lode e di ringraziamento .
Gli scritti del Corpus
Hermeticum permettono di determinare con chiarezza la natura e
il contenuto della gnosi.
La conoscenza non è frutto
di sforzi intellettuali, ma deriva da una rivelazione di dio,
che vuole essere riconosciuto dai suoi. Per questo la gnosi è per
sua natura una conoscenza che non può
essere raggiunta attraverso
la riflessione filosofica, ma che si compie in una trasformazione
completa dell'uomo, colmato di una forza divina che si unisce
alla scintilla divina sopita in lui, e che lo porta alla vera
vita. ..."
 Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.
Monumento della cultura gnostica ?
Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.
Monumento della cultura gnostica ?L’ipogeo degli Aureli (detto anche di Aurelio Felicissimo) è un monumento funebre privato,postosull’antica via Labicana, nell’attuale rione Esquilino. Il cimitero venne scoperto nel 1919 all’incrocio tra viale Manzoni e via Luzzatti, e suscitò l’ammirazione degli studiosi per il ricco ciclo di affreschi che adorna le pareti e la cui interpretazione resta ancora oggi un problema aperto.
Il monumento, che non è menzionato in nessuna fonte letteraria, fu scoperto durante i lavori di costruzione di un garage. Esso si presenta a due piani: il piano superiore, composto da una sala che in origine era semi-ipogea e di cui oggi resta solo la parte inferiore; e, cinque metri sotto, il piano inferiore, composto da due ambienti speculari e completamente ipogei.
Gli ambienti sono affrescati con scene di difficile interpretazione, ma databili intorno al 230. Con la costruzione delle Mura aureliane e il conseguente allargamento del pomerio, il cimitero fu abbandonato.
Il nome dell'ipogeo deriva da uno dei due ambienti sotterranei, detto cubicolo degli Aureli, il cui pavimento è ricoperto da un mosaico in cui Aurelius Felicissimus dedica il sepolcro ai fratelli Aurelius Onesimus, Aureliius Papirius e Aurelia Prima. Ad una parete è affissa un'epigrafe marmorea in cui tale Aurelius Martinus e la moglie Iulia Lydia ricordano la figlia defunta Aurelia Myrsina.
 Nel
locale superiore troviamo raffigurati
Adamo ed Eva senza il “segno
di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero
della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore
della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo
e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne
di fronte al Demiurgo.
Nel
locale superiore troviamo raffigurati
Adamo ed Eva senza il “segno
di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero
della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore
della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo
e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne
di fronte al Demiurgo. La Conoscenza (Gnosis) apportata da Naas è la Conoscenza del Bene e del Male , una Conoscenza Etica ed Ontologica.
A lato della figura di Adamo ed Eva con il Serpente (Naas) sulla destra troviamo dipinta una figura di maestro con un rotolo in mano nell’atto di insegnare. Si tratta forse di una figura di Maestro Gnostico, depositario dell’antica Conoscenza trasmessa da Naas ai progenitori.
Sempre a lato della figura di Adamo ed Eva, ma alla sua sinistra troviamo raffigurata una figura grande di uomo con pallio con a lato una figura antropomorfica dalle dimensioni più piccole, che rappresenta forse il Demiurgo. La scena raffigura l’atto della Creazione dell’Uomo ad opera del Demiurgo .
 Nel
primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi
sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,
in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il
Salvatore, circondato da una specie di
corona con dei piccoli raggi.
Nel
primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi
sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,
in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il
Salvatore, circondato da una specie di
corona con dei piccoli raggi.L'insegnamento trasmesso dal Salvatore si può attingere soltanto guardandolo dal punto di vista degli Apostoli. Gli apostoli sono raffigurati in atteggiamento magistrale con un rotolo nella mano.
In un caso abbiamo addirittura un evangelista, probabilmente Giovanni, raffigurato con la mano contemporaneamente rivolta verso l’alto nell’atto di insegnare e verso il basso nell’atto di stringere un rotolo.
Sul soffitto troviamo dipinta una donna velata con due uomini ai lati, di cui uno con un bastone in mano rivolto verso il capo della donna.
... Mentre nel Corpus Hermeticum non si fa menzione di gruppi religiosi, la conoscenza gnostica può essere associata anche a comunità di credenti che continuino quelle tradizionali o siano costituite in modo nuovo.
Le concezioni gnostiche sono così presentate spesso sotto forma di celebrazioni cultuali del tipo di quelle delle comunità misteriche, o assumono tratti cristiani; sorgono così comunità miranti a nobilitare il vangelo attraverso il mito gnostico.
Le idee gnostiche possono anche essere semplicemente riportate in una predicazione rivolta a coloro cui è annunciata la conoscenza salvifica. Così gli scritti ermetici non sono rivolti a cerchie predeterminate di persone che si radunino per il culto, ma intende risvegliare i lettori invitandoli a incamminarsi lungo la strada della conoscenza.
I temi fondamentali presi in considerazione nel primo trattato vengono continuamente ripresi negli altri, ripetuti in diverse forme. Dalla serie di questi scritti si distingue soprattutto il tredicesimo trattato, che verte sulla rigenerazione dell'uomo: non nel senso di un atto sacramentale, ma solo della conoscenza di dio. All'inizio si afferma che nessuno può essere salvato prima della rigenerazione ; per questo è necessario apprenderne la dottrina, che libera dall'inganno del cosmo.
DISCLAIMER. Si ricorda - ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 - che questo sito non ha scopi di lucro, è di sola lettura e non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare" : gli aggiornamenti sono effettuati senza scadenze predeterminate. Non può essere in alcun modo ritenuto un periodico ai sensi delle leggi vigenti né una "pubblicazione" strictu sensu. Alcuni testi e immagini sono reperiti dalla rete : preghiamo gli autori di comunicarci eventuali inesattezze nella citazione delle fonti o irregolarità nel loro uso.Il contenuto del sito è sotto licenza Creative Commons Attribution 2.5 eccetto dove altrimenti dichiarato.