“Noi siamo, e quindi pensiamo; e pensiamo solo nella misura in cui siamo, dal momento che il pensare è causato dalle strutture e dalle attività dell’essere” NEUROETICA : UNA VISITA GUIDATAdi ALDO TRUCCHIO scienzaefilosofia.it
Questo testo non è tanto un’introduzione, quanto una ‘visita guidata’ alla neuroetica, nella quale chi scrive rinvierà direttamente tramite link alle numerosissime risorse in Rete sul tema per soffermarsi, invece, sui confini, le sovrapposizioni, le difficoltà, e il quadro antropologico‐politico che caratterizzano questo nuovo campo di indagine.1. Dalla bioetica alla neuroetica
2. La tesi di parità
3. Etica, diritto e neuroscienze
4. Filosofia della mente e neuroscienze
5. La percezione delle neuroscienze
1. Dalla bioetica alla neuroetica
"Incominciamo richiamando rapidamente alla mente una storia piuttosto nota.
A partire dagli anni ’60 dello scorso secolo i rapidi sviluppi della tecnologia medica hanno permesso di rinviare più o meno indefinitamente la morte biologica di un individuo e di sviluppare numerose metodologie di riproduzione artificiale.
Nello stesso tempo, gli specialisti coinvolti a vario titolo in questo progresso si erano specializzati sempre più nei rispettivi campi di ricerca e si rendeva dunque necessario recuperare un’ottica interdisciplinare.
La nascita della bioetica all’inizio degli anni ’70 scaturisce dunque da un’urgenza, da una parte per far tornare a far dialogare tra loro medici e ricercatori, e poi anche giuristi e studiosi di etica, dall’altra per indurre una sorta di responsabilizzazione e autoregolazione da parte dei ricercatori in campo medico attraverso il confronto su quei valori umani fondamentali che finivano per essere inevitabilmente messi in discussione nelle loro scoperte.
La bioetica si occupò inizialmente di stabilire il diritto del paziente a decidere di sé contro il paternalismo dei medici; cioè, per dirla in maniera più semplice, di tematiche quali l’eutanasia, l’aborto, la fecondazione assistita, il trapianto di organi e, più di recente, dell’ingegneria genetica.
Ma l’istituzionalizzazione della discussione bioetica ha portato a un suo isterilimento, quando non apertamente al capovolgimento delle sue istanze originarie.
Dietro le cattedre universitarie e nei comitati finanziati dai governi si è iniziato ben presto a mediare tra istanze politico‐religiose più che a far dialogare gli specialisti dei vari settori, col risultato che gli esiti di queste discussioni finiscono per essere completamente distaccati dalla realtà, e quindi paternalistici o meramente prescrittivi, fondati su principi generali, intuizioni e tradizioni, più che sulla pratica medica quotidiana e sulla ricerca che così finisce semplicemente per risultarne ostacolata – si vedano in proposito i testi di
Jonathan Baron
e di Albert Jonsen (
Journal of Medicine and Philosophy
25 (6):689 – 699 (2000) .
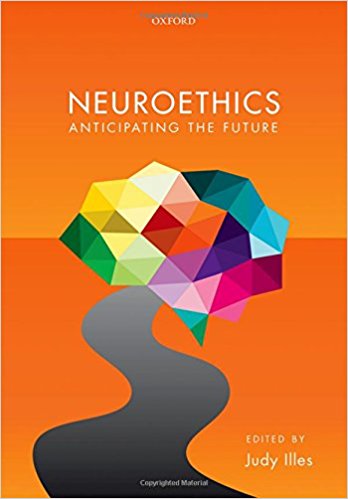 Questa breve e sicuramente riduttiva premessa è tuttavia necessaria perché la definizione di neuroetica è evidentemente modellata su quella di bioetica: la migliore e più semplice è probabilmente quella di Judy Illes che, ricalcando la definizione di bioetica del 1971 dell’oncologo statunitense Van Rensselaer Potter richiama il legame tra nuove conoscenze biologiche e le classiche conoscenze sui valori umani .
Questa breve e sicuramente riduttiva premessa è tuttavia necessaria perché la definizione di neuroetica è evidentemente modellata su quella di bioetica: la migliore e più semplice è probabilmente quella di Judy Illes che, ricalcando la definizione di bioetica del 1971 dell’oncologo statunitense Van Rensselaer Potter richiama il legame tra nuove conoscenze biologiche e le classiche conoscenze sui valori umani .
Si vedano in proposito le interessanti pubblicazioni del
National Core for Bioethics
dell’UBC diretto dalla Illes – tra le quali una riflessione dedicata allo sviluppo di una neuroetica clinica.
Perciò, a dieci anni dalla sua nascita, nel momento in cui si viene chiamati a presentarne, anche schematicamente, i primi risultati, non si può fare a meno di denunciare preventivamente il pericolo che la neuroetica corre di sclerotizzarsi in una serie di variazioni su canovacci sempre uguali.
Come in parte, del resto, sta già avvenendo: chiunque può appurare, tramite una veloce ricerca in biblioteca o in Internet, che la maggior parte degli studi su questi temi presentano, quasi fossero delle convenzioni stilistiche, alcuni passaggi sempre uguali, con il loro corredo standard di casi clinici ed esperimenti mentali.
Non è questo il luogo per una riflessione foucaultiana sul perché nascano e si diffondano certi discorsi scientifici e filosofici piuttosto che altri, e quindi sulle relazioni di potere che a essi presiedono – anche se non potremo esimerci dal riproporre tale questione tra qualche pagina – però è evidente che la moltiplicazione anche ridondante di studi sull’etica delle neuroscienze è stata favorita dalla straordinaria quantità di investimenti che nel decennio precedente alla sua nascita sono stati utilizzati per l’acquisto, da parte di istituti pubblici e privati, di macchinari destinati all’elaborazione di immagini e dati provenienti dal sistema nervoso centrale.
Lo stesso Michael Gazzaniga, che in quanto neuroscienziato e membro del
President’s Council on Bioethics
degli USA non è certo sospettabile di eccessiva vis critica nei confronti di questa disciplina, ammette ironicamente che in un certo lasso di tempo bastava che un dipartimento inserisse le parole ‘cervello’ o ‘scienze cognitive’ nel suo nome per vedere aumentare in maniera notevole le sue risorse economiche – anche se rimaneva lo stesso dipartimento di psicologia di prima!
2. La tesi di parità
La neuroetica fin dall’inizio comprende al suo interno tre distinti campi di riflessione.
Il primo riguarda i problemi etici, morali e giuridici legati alle possibilità aperte dalle neurotecnologie, le cui principali sono raggruppate sotto il nome di
functional neuroimaging
e che sono in grado di misurare l’attività del cervello, in particolare correlando l’attività di specifiche aree del cervello a specifiche funzioni mentali.
Il secondo è legato ai problemi filosofici sulla natura e il funzionamento della mente, cioè a problemi classici quali il libero arbitrio, il dualismo mente/corpo, l’unità del sé, ecc. Si tratta evidentemente di domande che accompagnano l’uomo da sempre, però stavolta esaminate alla luce delle nuove immagini del cervello delle quali disponiamo.
Infine la neuroetica si preoccupa della maniera nella quale le nuove conoscenze vengono comunicate e percepite al grande pubblico dei non addetti ai lavori; in tal modo la neuroetica si sovrappone all’etica della comunicazione scientifica.
Ma il mio ruolo di guida mi impone anche di dichiarare preventivamente i criteri che mi hanno portato alla scelta di un percorso piuttosto che un altro.
Quindi premetto di adottare quella che Neil Levy – tra l’altro direttore di «Neuroethics» – ha definito ‘tesi di parità’ nella convinzione che non esista, è forse l’esempio più semplice, un salto qualitativo tra i nuovi modi di alterare la mente tramite psicofarmaci e quelli più vecchi e familiari, dal caffè all’oppio.
Da questa prospettiva si sarà più liberi di guardare in maniera serena ai farmaci che sono in grado di curare gravi patologie (o di incrementare le capacità di soggetti sani) e che però inducono una qualche modificazione del tono dell’umore o del comportamento usuali.
Lo stesso discorso vale per gli strumenti più o meno invasivi che permettono di orientare o addirittura anticipare delle scelte, che gli esperti di marketing conoscono e utilizzano da tempo pur senza aver mai studiato l’anatomia del cervello.
Ma soprattutto, e qui supero in un certo qual modo l’approccio tutto sommato generico e moderato di Levy, sostengo che se la tesi di parità può essere una valida premessa è perché la visione stessa della realtà che le neuroscienze ci offrono, l’ontologia e l’antropologia che stanno alla loro base, sono quelle appartenenti tipicamente alla nostra modernità, almeno nella maniera nella quale è stata recepita e fatta propria dal senso comune – si pensi ad esempio alla tesi anticartesiana e neojamesiana, nonché esplicitamente ispirata dalla lettura dell’Ethica di Spinoza, che ha reso celebre Damasio e che è al centro della sua ‘trilogia’ (Descartes’ Error [1994], The Feelings of What Happens [1999], Looking for Spinoza [2003]): le emozioni non riguardino esclusivamente il cervello, ma nascano dall’insieme integrato mente‐cervello‐corpo.
Per quanto i
divulgatori delle neuroscienze
e i neuroeticisti più accorti si preoccupino spesso di complicare il riduzionismo, il materialismo e il
localizzazionismo
che fanno da sfondo alle ricerche degli sperimentatori,
le metodologie attuali di studi del cervello
nascono in seguito all’osservazione delle modificazioni del comportamento seguite a danneggiamenti casuali (o intenzionali, sugli animali da laboratorio e su pazienti sottoposto a intervento chirurgico per curare varie patologie) di parti di esso – mi riferisco ovviamente ai sempre citati casi seguiti da Broca e da Wernicke, agli esperimenti di Fritsch e Hitzig sui cani e alla celebre vicenda di
Phineas Gage
.
Detto in maniera brutale, secondo le neuroscienze, che sono confortate in questo da innumerevoli evidenze sperimentali, la forma e la grandezza dei lobi prefrontali può dirci qualcosa del carattere, dell’indole di qualcuno, addirittura segnalare la possibilità che venga messo in atto un comportamento antisociale anche in chi non ha mai mostrato inclinazioni in tal senso, né più, né meno di come potevano fare la fronte e gli zigomi per Lombroso.
Al di là delle costruzioni teoriche, la pratica dei neuroscienziati è sempre materialistica, riduzionistica e localizzazionista: ad esempio quando una epilessia grave viene curata individuando l’area del cervello che la genera e asportandola chirurgicamente – dopo ovviamente aver previsto con la maggiore esattezza possibile i problemi che la mutilazione comporterà per l’interessato e quindi aver calcolato il rapporto costi‐benefici dell’operazione; o quando gli psichiatri riconducono un gran numero di disagi psichici alla carenza di serotonina e quindi prescrivono farmaci che ne inibiscono la ricaptazione da parte del neurone pre‐sinaptico.
In altre parole, una precisa zona del cervello presiede a una precisa funzione, anche molto elevata, della mente, come il linguaggio o la coscienza stessa; e regolando una secrezione si possono modificare l’umore e il comportamento, la percezione di sé e del mondo.
Non occorrerà insistere ancora su questo punto.
Se le neuroscienze affascinano e assieme incutono tanto timore, se sono
Unheimlichen
, per dirla con Freud, è proprio perché posseggono la capacità di osservare e assieme di modificare, e quindi di mettere in dubbio ciò che noi più profondamente e intimamente sentiamo di essere.
3. Etica, diritto e neuroscienze
La tesi di parità che abbiamo preventivamente dichiarato di adottare ci consente di bypassare alcune questioni sulle quali pure sono state scritte molte pagine ed alle quali possiamo approcciare semplicemente attraverso due esempi.
Si è scoperto che il donepezil, sintetizzato per ridurre la perdita di memoria nelle persone affette dal Morbo di Alzheimer, potenzia la capacità di memorizzazione anche nelle persone sane; la notizia che moltissimi scienziati e studiosi USA, oltre che semplici studenti, per incrementare le proprie prestazioni fanno un uso sistematico del metilfenidato, inizialmente pensato per trattare il deficit di attenzione nei bambini iperattivi (ADHD), fece qualche tempo fa il giro del mondo.
Ma se gli studiosi attenti alle tematiche etiche nelle neuroscienze si mettessero a discutere sulle limitazioni alla vendita o, peggio, alle dosi consentite al di fuori dell’uso curativo, come se si trattasse semplicemente di un doping del cervello e come se la ricerca fosse una gara di atletica, ripeterebbero l’errore di molti bioeticisti.
Se esistono e circolano delle sostanze che possono migliorare la vita delle persone, saranno inevitabilmente utilizzate, e il limite al loro impiego sarà dettato dagli effetti collaterali, in senso ampio, che gli utilizzatori sperimenteranno.
Il pericolo che una utilizzazione prolungata del donepezil renda incancellabili e ossessivi dei ricordi, cioè che generi praticamente una sorta di disturbo post‐traumatico senza trauma, è abbastanza spaventoso da tenere lontana da esso la maggior parte delle persone; allo stesso modo, il metilfenidato è una anfetamina, anche se con effetti, anche collaterali, piuttosto blandi, e se la maggior parte di noi continuerà a preferirgli un caffè non è perché questo è consentito, ma per lo stesso motivo per il quale erano in pochi a iniziare la propria giornata con una dose di cocaina anche quando era legale farlo.
Piuttosto occorrerebbe utilizzare questi casi per vedere ancora più chiaramente come la ricerca scientifica, che per definizione è fatta da gruppi di persone che condividono le loro conoscenze, e da strutture e mezzi tecnici assai complessi, venga invece percepita come una competizione tra individui.
Il che, forse, ha molti punti di contatto col fatto che istituzioni scolastiche e genitori deleghino a una pasticca il compito di mettere a tacere un segnale di disagio dei bambini, quale è effettivamente l’iperattività, ancora una volta allo scopo di incrementarne le prestazioni scolastiche. Invece, se la neuroetica incrementerà la sua importanza come disciplina autonoma, sarà sicuramente dovuto al ruolo di mediazione che può giocare tra diritto e nuove conoscenze neuroscientifiche.
Le recenti scoperte in questo campo, difatti, che ci obbligano a ripensare il sé, la coscienza e la libertà di scelta, hanno delle ricadute immediatamente pratiche rispetto alla maniera nella quale il diritto ha codificato e ratificato ufficialmente il senso comune.
Micheal Gazzaniga, a seguito di test eseguiti su pazienti
split brain
– nei quali, cioè, è stato reciso il corpo calloso che collega i due emisferi cerebrali per curare una epilessia gravemente invalidante – ha localizzato sperimentalmente una determinata area del cervello, nell’emisfero sinistro, deputata a interpretare le informazioni provenienti dal mondo esterno e integrarle in un resoconto coerente con l’immagine che si ha di sé, meglio, con la narrazione della quale ci si sente protagonisti.
Questa area, chiamata appunto
‘interprete’,
pur di conservare una sua logicità è disposta a riempire arbitrariamente i vuoti nei dati conservati della memoria con elementi solo apparentemente coerenti con la situazione realmente vissuta. In tal modo l’interprete diviene un vero e proprio ‘creatore di credenze’ allo scopo di ovviare a vuoti, scarti e incoerenze nei ricordi. Un esempio di una distorsione dovuta (presumibilmente) all’interprete ci è fornito dallo stesso Gazzaniga e riguarda un fatto decisamente noto: nel 2002 i cittadini di Washington D.C., Virginia e Maryland erano terrorizzati dalla presenza per le strade di un cecchino che per settimane uccise persone a caso.
Uno dei testimoni di un omicidio asserì con grande sicurezza di aver visto il cecchino sparare da un furgoncino bianco. In realtà come fu poi possibile appurare, egli aveva effettivamente udito gli spari e visto una persona essere colpita, ma il cecchino sparava da una auto blu al di fuori della sua vista, mentre un furgoncino bianco era parcheggiato lì di fronte.
In tal modo il fatto ‘so che qualcuno ha sparato’, di fronte al vuoto creato dalla domanda ‘da dove’ è stato completato dal dato ‘furgoncino bianco’ in maniera da costituire un quadro coerente della situazione. Ma la cosa più interessante è che di seguito alla pubblicazione di questa testimonianza sui giornali molti altri testimoni degli omicidi videro provenire gli spari da un furgoncino bianco.
Per di più studi come questo mostrano come sia possibile, semplicemente attraverso una serie di domande capziose, influenzare in maniera estremamente rilevante i ricordi di un soggetto: una volta che questi abbia abboccato a un falso ricordo indotto, anche piuttosto irrilevante, la sua stessa mente inventerà un gran numero di nuovi falsi ricordi per integrarlo in maniera coerente nella propria narrazione autobiografica.
L’unica conclusione possibile è che non possiamo più lecitamente fidarci di nessuna testimonianza oculare. Se si pensa allora che circa il 90% delle sentenze si basa proprio su testimonianze oculari, le implicazioni giuridiche di questa scoperta saranno subito chiare.
Allo stesso modo le neuroscienze ci costringono a ripensare la classica definizione di ‘capace di intendere e di volere’: innanzitutto, sappiamo che la coscienza e la consapevolezza sono due cose distinte.
[ cf. anche
tesi
]
Se una certa area del cervello viene danneggiata, il soggetto semplicemente continuerà a permanere in uno stato di incoscienza senza nessuna possibilità di ‘risvegliarsi’: l’interruttore è spento, punto. Ma oggi sappiamo anche che la consapevolezza di stare facendo, o di stare subendo qualcosa è in ritardo di circa un terzo o anche di mezzo secondo rispetto allo stimolo iniziale – e che di conseguenza la maggior parte delle nostre azioni sono intraprese prima, se non al di là di una riflessione cosciente, proprio come quando pigiamo il freno dell’auto per evitare un ostacolo improvviso – mi riferisco al celebre
esperimento di Libet
ed alle successive verifiche sperimentali di Wegner ( Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious will. Cambridge, MA: MIT Press.)
Ma se mentre sto guidando freno per evitare di investire un pedone distratto, questo può essere considerato una azione morale, anche se avviene al di fuori della mia consapevolezza? Questo spazio tra lo stimolo e la consapevolezza può essere enormemente dilatato da diverse patologie, alcune delle quali ancora poco conosciute, la più nota è il sonnambulismo.
Già più volte i tribunali hanno ridotto le pene o assolto gli imputati di crimini, persino di omicidi, avvenuti in tali condizioni; ma il discrimine tra consapevole e inconsapevole diventa sempre più sfumato man mano che le nostre conoscenze crescono – e si complicano.
Ciò che stiamo scoprendo con le neuroscienze è che la maggior parte delle nostre decisioni viene presa in uno spazio che non è quello della consapevolezza, e quindi somiglia di più ad automatismi, a riflessi; in tal modo salta necessariamente anche lo spazio tra volontarietà e involontarietà di una azione, che pure è fondamentale per il diritto.
L’immagine che le neuroscienze ci restituiscono di noi è sempre deterministica: ogni mia azione è determinata, in ultima analisi dalla conformazione stessa del mio sistema nervoso centrale, che a sua volta è il risultato del contesto sociale nel quale viviamo, degli incontri e degli eventi della nostra vita, cioè a qualcosa che non possiamo semplicemente controllare.
Riflessioni di questo tipo torneranno quando tratteremo delle implicazioni filosofiche delle neuroscienze – si sta parlando evidentemente di libero arbitrio! – ma per adesso preferisco sottolineare come stia prevalendo un approccio pragmatico alla questione.
Di fronte a chi afferma che non credere nel libero arbitrio, e quindi nella possibilità di scegliere tra il bene e il male, significa distruggere le fondamenta stesse del sistema della punizione dei crimini, l’impostazione più diffusa, ad esempio, tra i membri del
Law and Neurosciences Project
o del
Gruter Institute
, è quella di considerare invece il determinismo come un dato di fatto e l’idea di libero arbitrio come del tutto inessenziale al corretto funzionamento del sistema di giustizia criminale.
Semplicemente, la punizione non viene più considerata come ‘dare al criminale ciò che si merita’, ma come un ‘difendere la società’ da individui pericolosi.
È esattamente la stessa risposta che Baruch Spinoza diede nell’epistola LXXVIII a chi gli opponeva la medesima obiezione: «il cane che diventa idrofobo per un morso non è responsabile, e tuttavia è giustamente soppresso; e così anche chi non è in grado di regolare le sue passioni e di contenerle col timore delle leggi, quand’anche sia scusabile per la sua debolezza […] necessariamente perisce».
Ancora una volta sottolineo en passant come le neuroscienze non facciano altro che recepire la metafisica moderna, quella di Spinoza e Hobbes, che è in fondo quella del Cartesio della res extensa, e assieme prendere atto delle implicazioni della scienza sperimentale di Galileo e di Newton. In tal senso, più che una svolta, esse rappresentano finalmente la diffusione e l’accettazione pubblica delle più elementari implicazioni della nostra modernità, cioè appunto materialismo e riduzionismo.
Anche se, a ben vedere l’immagine che, ad esempio, Spinoza elaborò dell’uomo e della società era già ben più complessa di quella che oggi ci viene propinata dalla divulgazione scientifica – e ci sarebbe poi da dire che la scienza ha già da tempo superato quella visione del mondo, ad esempio con la fisica quantistica.
Sebbene l’impostazione metafisica sia la stessa, difatti, lo sviluppo tecnologico rende inquietanti alcune conclusioni elaborate in questi centri di studio, cioè che esistono oggi dei sistemi di controllo sociale più (economicamente) efficaci della minaccia del carcere e che si basano piuttosto sulla prevenzione dei crimini.
La gamma di possibilità di controllo offerte dalle nuove tecnologie è effettivamente straordinariamente ampia: la tesi di parità ci porta a ritenere che i nuovi mezzi per controllare e influenzare le menti siano più potenti, ma non essenzialmente differenti da quelli del passato.
Tuttavia proprio il cambio di mentalità avvenuto negli ultimi decenni, cioè l’accettazione diffusa di materialismo e riduzionismo, ha fatto sì che astrazioni come le idee, le intenzioni, l’indole, l’anima, che prima venivano ritenuti inaccessibili al fondo della nostra intimità, siano adesso entrate nell’orbita del visibile, dell’indagabile, dell’osservabile oggettivamente – si guardi ad esempio il servizio di
60 Minuts
proprio sul fMRI !
Anche qui sarò un po’ semplicistico per arrivare subito al punto. Se una persona commette un reato perché determinato a farlo, come si è detto prima, piuttosto che incarcerarlo ex post sarebbe meglio osservare la catena di eventi che porta al delitto e interromperla; ma allora deve essere possibile anche osservare l’intenzione, se non addirittura la tendenza o la predisposizione alla delinquenza prima che il comportamento illegale venga posto in atto – come forse sembra suggerire Stephen J. Morse.
Numerosi studiosi si sono precipitati a affermare che tutto ciò non è ancora possibile e che forse non lo sarà mai; che ogni predisposizione al delitto, sia essa genetica, psicologica o derivante da traumi o patologie, viene attivata sempre dall’ambiente e da esso dipende per la maggior parte. Il problema, ed è questo il punto a cui volevo arrivare, non è più eticoscientifico, ma politico.
Le idee che un comportamento antisociale possa essere dettato dalla atrofia dei lobi pretemporali, o che le ‘cattive intenzioni’ siano visibili tramite le tecniche di fnRMI ( imaging con risonanza magnetica), sono ormai assai diffuse, per quanto solo in parte vere. Però è nato intorno a queste scoperte scientifiche un vero e proprio discorso ideologico, che è condizione di possibilità di un passaggio politico. Effettuare una scansione del cervello allo scopo di trovare simili riscontri in chi vuole entrare in polizia, o nei candidati a un posto di lavoro, a chi chiede un permesso di soggiorno, a chi deve prendere un aeroplano o addirittura a tutti quelli che si sottopongono a controllo medico, ha il solo scopo di immettere nella società un ulteriore, estremo elemento di controllo biopolitico.
Qui si tratta della possibilità che hanno le istituzioni statali di controllare enormi masse di persone – i pretesti per farlo non mancano mai – di mettere le mani sulle menti oltre che sui corpi, anche se le tecniche per farlo sono ancora decisamente rozze; e se lo faranno o meno non dipende da quanto convincenti saranno i saggi dei neuroeticisti, ma da un effettivo scontro di forze tra controllori e controllati, tra chi ha bisogno di spostarsi per cercare una vita migliore e chi vede nella mobilità sociale un elemento di destabilizzazione, tra chi lavora per vivere e chi ha bisogno che tutta la vita sia lavoro.
4. Filosofia della mente e neuroscienze
L'esternalismo ( teorie della mente estesa) non nega il fatto ovvio che, senza il cervello e il sistema nervoso, non si ha nessuna mente ma mette in discussione :
1) che il cervello sia sufficiente a produrre la mente
2) che il cervello (o quello che i neuroni fanno o le loro proprietà) siano l'unica base fisica per i processi e/o i contenuti mentali.Dovrebbe già risultare chiaro che i classici problemi della filosofia della mente hanno tratto nuova linfa dalle neurotecnologie; però non si può tacere del fatto che non hanno trovato nuove soluzioni, ma, al limite, conferme sperimentali di antichi modelli.
Allora anziché elencare i problemi e poi proporre una soluzione, mi limiterò ad attraversare alcune questioni accogliendo sostanzialmente
la teoria della ‘mente estesa’
di Clark e Chalmers – ma se lo faccio, devo confessare, è perché questa teoria non può non richiamare alla mente l’idea marxiana di General Intellect, così come le riflessioni di quanti hanno visto nel sociale non l’opposto, né la premessa del privato, ma il luogo effettivo dell’individuazione, da Vygotskij a Simondon, da Machiavelli a Spinoza.
La teoria della ‘mente estesa' . Questa concezione della mente umana può essere così sintetizzata: se qualcosa svolge un ruolo nell’attività cognitiva può essere considerata parte della mente, anche se non è interna al nostro corpo.
Se per raggiungere un certo luogo cerchiamo di ricordare le indicazioni che ci sono state date, prendiamo un appunto dal portafoglio o chiediamo a un passante, gli appunti e il passante hanno la stessa funzione cognitiva della nostra memoria interna e quindi fanno parte della nostra mente.
Gli esseri umani non hanno una rappresentazione interna della realtà molto ricca, al contrario di quello che si pensa comunemente. Siamo piuttosto evolutivamente programmati per risparmiare risorse cognitive e quindi solitamente formiamo solo uno schizzo della realtà – è una esperienza condivisa più o meno da tutti quella di frequentare un luogo per anni e con accorgersi di un particolare importante dell’arredamento fin quando la nostra attenzione non viene portata specificatamente su di esso.
È per questa apparente incapacità, però, che gli uomini hanno la possibilità di perdersi, cosa sconosciuta, almeno in senso proprio a molti animali, che invece hanno mappe mentali estremamente dettagliate, basti pensare agli uccelli migratori o alle api.
Ma la possibilità di perdersi implica anche quella di trovare nuovi percorsi, cioè di complicare la propria relazione con l’ambiente esterno. E per questo necessitiamo di strumenti esterni che ci aiutino a orientarci nel mondo e che, svolgendo una funzione cognitiva, possono essere considerati parte della mente, dai blocnotes ai computer portatili.
Ma vorrei anche provare a rendere più radicale la teoria della mente estesa , pensando che gli strumenti che utilizziamo come estensioni della nostra mente sono essi stessi il prodotto di altre menti e altri strumenti, che in essi è condensata una conoscenza sociale nel senso di essere stata creata nel corso dei secoli attraverso l’accumulazione e la sovrapposizione di conoscenze e strumenti via via più complessi da parte dell’intera collettività.
E anche che la nostra mente è il prodotto di quella storia, cioè di una evoluzione prima biologica e poi sociale, non fosse altro che perché la nostra coscienza è prevalentemente linguistica e il linguaggio è il prodotto sociale per eccellenza.
Di propriamente nostro, nella mente estesa, non c’è poi molto. Allora proviamo a guardare da questa prospettiva ai più tipici problemi che la filosofia della mente pone alle neuroscienze.
Un primo classico argomento riguarda la possibilità – o l’opportunità, a seguito di un evento traumatico – di cancellare spezzoni della memoria individuale; o di inserirne di nuovi.
Ma se la mente cognitiva è estesa ai supporti esterni ed agli altri, le possibilità di creare qualcosa che non venga percepito come sogno o un’allucinazione sono ridotte a zero. Anche se si potesse instillare in un individuo un falso ricordo, difatti, sarebbe impossibile modificare di conseguenza l’intero contesto sociale nel quale l’individuo è inserito e che conserva e testimonia assieme a quello degli eventi della sua vita.
Il problema della memoria è intimamente connesso con quello del sé individuale: un argomento di tipo filosofico spesso usato contro gli psicofarmaci e a favore della psicoanalisi è che i primi modificano dall’esterno e in maniera passiva la percezione della propria realtà e quindi il carattere e il comportamento degli individui, cioè un supposto ‘sé autentico’, mentre nella seconda un percorso di cambiamento vede l’individuo come parte attiva – si veda in proposito lo studio di
Felicitas Kraemer
su pazienti ammalati di Parkinson.
Secondo chi scrive , un percorso psicoanalitico è sicuramente preferibile, e proprio per la motivazione addotta, all’utilizzazione degli psicofarmaci. Ma in certi casi la comprensione delle motivazioni profonde che causano un disagio non elimina il disagio stesso; che può essere motivato e salutare, quando scatena alla fine una reazione, ma anche patologico.
Una perdita – un lutto, una separazione, una perdita di ruolo sociale o di capacità economica – genera sempre e inevitabilmente una reazione di tipo depressivo – anzi l’assenza di una reazione di questo tipo sarebbe da considerare patologica.
Ma se la depressione si prolunga oltre un certo periodo di tempo, o è accompagnata da alterazioni gravi del comportamento, o dà luogo a una prostrazione che impedisce le normali attività della vita, diviene inevitabile pensare di ricorrere a rimedi chimici. Non so se noi siamo macchine, ma di certo per le neuroscienze noi siamo un insieme complesso di meccanismi che possiamo consapevolmente modificare.
Quando Cristopher DeCharms promette di rendere controllabili alcune aree del cervello che presiedono, ad esempio, al dolore sia fisico che psicologico, tramite la visualizzazione in tempo reale dell’attività del proprio cervello attraverso rtfMRI (
real-time functional magnetic resonance imaging
) , anche se sta forse parlando di una pratica che incrementa l’autoconsapevolezza come certe tecniche di meditazione di origine orientale, la sua presentazione e il suo fare da imbonitore sono realmente spaventosi.
Ma, in fondo, anche quando siamo stanchi, o stressati, o tristi e ci prescriviamo una passeggiata al sole, un po’ di sport o una birra con gli amici lo facciamo perché siamo consapevoli che quegli stimoli esterni modificheranno la nostra intimità – in maniera quantitativamente, ma non qualitativamente differente dagli psicofarmaci.
Ancora, dalla questione dell’autentico sé si giunge a quella dell’autocontrollo: una persona che si ripromette di smettere di fumare e poi non ci riesce, in quale delle sue due versioni, quella salutista o quella viziosa, è realmente se stessa? Perché una prende il sopravvento sull’altra?
Ebbene anche qui la risposta è semplice se elaborata a partire dalla teoria della mente estesa, anche nella versione semplificata e rafforzata che qui si sostiene. L’ambiente esterno fornisce stimoli in un senso o in un altro – presso il National Core for Neuroethics si è discusso ad esempio della necessità di un biopsychosocial approach – e molte verifiche sperimentali attestano che la resistenza a una tentazione è legata, più che alla sua intensità, alla sua permanenza nel tempo.
A questo tipo di studi, del resto, sono legate anche molte analisi di quelle nuove discipline che sono state definite neuromarketing e neuropolitics: lo stimolo ad acquistare, a consumare, o a votare, diviene man mano più intenso quanto più è prolungata nel tempo l’esposizione al prodotto stesso e in maniera direttamente proporzionale alla stanchezza fisica e mentale. Ma questa cosa non aggiunge nulla a quanto chi si occupa dell’esposizione delle merci nei grandi magazzini conosce empiricamente da sempre.
Influenzare le scelte non è certo una abilità sviluppata di recente da parte del genere umano e la tesi di parità ci consente di tagliare corto su questo punto. Infine il libero arbitrio da questo punto di vista diviene forse il problema meno rilevante.
Non spetta alle neuroscienze stabilire se viviamo in un universo deterministico o indeterministico; e di certo il fatto che la cosiddetta
interpretazione di Copenhagen della meccanica quantistica
sia oggi prevalente non ci restituisce nessuna libertà: il caso non ci rende più liberi della causalità.
La libertà è per le neuroscienze come per ogni pensiero materialistico quella dell’autodeterminazione, e se si pensa che noi siamo per gran parte il prodotto dell’ambiente nel quale viviamo, ebbene sarà chiaro che la più grande libertà della quale possiamo godere è quella di modificare intenzionalmente quell’ambiente e incrementare in esso i fattori a noi favorevoli.
5. La percezione delle neuroscienze
Abbiamo accennato al fatto che esiste ormai una modalità codificata di scrivere libri di divulgazione sulle neuroscienze, che è fatta da casi clinici, esperimenti mentali, paradossi e un po’ di fantascienza; e anche al fatto che l’effetto di questa divulgazione è stato quello di diffondere una visione materialistica e determinista dell’essere umano. Ma in conclusione vorrei provare a superare questa semplicistica affermazione, perché in realtà la questione è più complessa.
Le neuroscienze, almeno nella loro comunicazione prevalente, forniscono nuovi argomenti, paradossalmente, anche a una visione antipolitica e premoderna della vita, a volte persino religiosa, addirittura a una sorta di filosofia della storia nella quale l’elemento storico è però ricondotto semplicisticamente a quello naturale. Un primo dato importante è l’interesse che alcuni ambienti della bioetica cattolica mostrano per le tecnologie di neuroimaging, che permettono di distinguere una gran varietà di stati mentali anche in pazienti privi di coscienza: la divulgazione fornisce spesso informazioni devianti che possono supportare l’idea che i pazienti in stato vegetativo permanente abbiano una vita mentale ricca e complessa. Non è così. Anche se alcune aree, anche importanti, del cervello, restano attive, in mancanza della capacità integrale quelle funzioni nessuna vita della mente è possibile.
Più importante è però ciò che avviene se si trascura l’importanza dell’elemento ambientale nello sviluppo del comportamento – e lo si fa spesso, magari in maniera involontaria, per semplificare giornalisticamente una scoperta magari assai complessa – i risultati che si ottengono sono, a ben vedere, sorprendenti.
Ad esempio l’idea – in fondo già introdotta dalla genetica – che alcune caratteristiche fisiche, nel senso di fisicamente riscontrabili, siano esse delle lesioni al sistema nervoso centrale o la presenza di certi geni nel DNA, predispongano a un certo tipo di comportamento, finiscono per reintrodurre una visione essenzialistica dell’essere umano, cioè proprio quella contro la quale Galileo o Spinoza elaborarono i propri sistemi di pensiero.
Mi spiego: la concezione semplicistica secondo la quale gli psicofarmaci hanno il potere di alterare un supposto sé autentico del quale abbiamo parlato prima, invece di confutare definitivamente l’esistenza di un centro assoluto e immodificabile che caratterizza l’individuo, ha finito per rafforzarla.
Se si pensa che il metilfenidato sia necessario per curare bambini distratti, o se si riscontra nella pratica che
i farmaci SSRI
fanno sì che persone depresse non lo siano più, o lo siano di meno, e se lo si fa senza prendere in considerazione le realtà sociali che quei comportamenti attivano, ciò che resta sarà l’immagine di individui isolati la cui natura o essenza è quella di essere distratti o depressi.
E se una anomalia al lobo frontale destro viene ritenuta indice di pericolosità sociale, allora esisteranno individui che, anche senza aver fatto nulla di male, saranno essenzialmente pericolosi.
In maniera speculare, dei comportamenti considerati sconvenienti e derivanti da un disagio sociale potranno facilmente essere classificati come problemi psichiatrici, invece che essere considerati manifestazioni di antagonismo sociale.
Forse la critica più forte che si può fare alla neuroetica è proprio la sua pericolosa ingenuità politica – per questo ho insistito tanto sulla teoria della mente estesa, che rende possibile evitare molte di queste ingenuità. Come
ho mostrato altrove
, difatti, ogni conflitto politico può essere relegato nella sfera del disagio mentale e ciò avviene, di fatto, anche nei testi dei neuroscienziati più filosoficamente accorti. Il patologico è considerato perversione di una fisiologia normale che, pur evidentemente non sottoposta preventivamente ad analisi clinica, viene data per scontata come sempre uguale, uniforme e maggioritaria nella popolazione I più noti studiosi e divulgatori delle questioni etiche nelle neuroscienze, da Damasio, a Gazzaniga, a Levy, riducono una complessità, il sociale, ai suoi elementi più semplici, gli individui considerati isolatamente.
Quindi spiegano il comportamento degli individui a partire da strutture neurali comuni a tutti, le più elementari possibili, ovviamente caratterizzate da
processi omeostatici
; per poi ritornare alla complessità pensandola come una mera accumulazione degli elementi semplici. Si tratta di un percorso tipicamente, ma ingenuamente, naturalistico.
Essi ricavano dalle neuroscienze una certa concezione della natura umana, ne illustrano i caratteri essenziali e di lì stabiliscono che una collettività sana, cioè pacifica e democratica, è fatta di individui sani, cioè rispondenti a un certo modello.
Una volta assunto che l’equilibrio omeostatico è la condizione verso la quale tendono gli organismi individuali e poi estesa agli organismi sociali, è inevitabile arrivare alla conclusione che la storia consista in un processo direzionato in maniera ben precisa verso la pacificazione e la diffusione di principi morali universali.
Ma qui siamo arrivati al confine, già sfiorato in precedenza, sul quale la neuroetica cede il passo all’ideologia ed alla politica. E quindi la nostra visita guidata è giunta al termine, mi resta solo il tempo per ringraziare Umberto di Porzio, Judy Illes e Neil Levy per i suggerimenti e i consigli in cuffia."
ETICA DIRITTO E NEUROSCIENZE
Pag. 2
Pag. 2
SOMMARIO
1 ( AGGIORNAMENTI )
2 (ETICA DIRITTO E NEUROSCIENZE )
3 (IL CERVELLO E LA SUA ETICA)
4 (BIOLOGIA DEI COMPORT. MORALI)
5 (NESSUNO E' COLPEVOLE ?)
6 (5 LIBRI PER ORIENTARSI)
7 ( VIDEO )
1 ( AGGIORNAMENTI )
2 (ETICA DIRITTO E NEUROSCIENZE )
3 (IL CERVELLO E LA SUA ETICA)
4 (BIOLOGIA DEI COMPORT. MORALI)
5 (NESSUNO E' COLPEVOLE ?)
6 (5 LIBRI PER ORIENTARSI)
7 ( VIDEO )